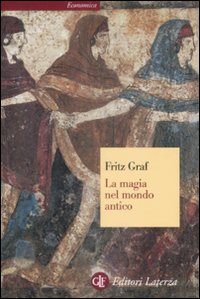Come sempre, sembro scomparsa ma non lo sono!
Il nuovo lavoro ha interrotto un po' i miei ritmi di studio e scrittura; tuttavia non mi sono persa d'animo e continuo a leggere, confrontare, esaminare... per quanto i nuovi impegni me lo consentano!
L'ultima "scoperta" è stata l'interessantissimo saggio di Fritz Graf
La magia del mondo antico, edito da Laterza. Un vero e proprio "gioiello", che mi ha chiarito molti dubbi sulla peculiarità della magia greco-romana.
E proprio perché sono rimasta colpita dall'intelligenza e completezza di questo testo, voglio condividere gli appunti presi durante la lettura dei diversi capitoli...
La terminologia grecaPer fare chiarezza all'interno del panorama variegato della magia antica (egiziana, greca e romana), sarà utile illustrare le diverse "famiglie" di termini utilizzati per specificare attività e peculiarità di chi praticava riti magici.
•
Gòes (da cui
goetéia, "stregoneria") non compare prima dell'età classica, ma si suppone che abbia un'origine ben più antica, collegata al
gòos, il pianto rituale: il
gòes è colui che, rovesciando l'esatto significato di
gòos, "fa uscire i morti dalle tombe" (cfr. Eschilo);
• parimenti antica è la parola
phàrmakon, che indica sia la medicina risanatrice sia il veleno (filtro magico) letale;
• simile al
phàrmacon è l'
epoidé, il rimedio magico;
• il più conosciuto (oggi) termine
màgos (con tutti i suoi derivati:
maghéia,
maghéuein...) è di origine persiana e, nell'ambito della magia antica, è una parola piuttosto recente. Presso i Persiani, il
màgos era l'esperto di religione e di riti religiosi; in Grecia viene a indicare colui che pratica
la maghéia, la quale a sua volta
comprendeva: - la divinazione- i culti misterici privati- la magia nociva o magia nera.
E' probabile che, in Grecia, la figura del
màgos si confondesse con quella dell'
agyrtes, indovino itinerante (spesso disprezzato dalla società e tuttavia temuto, proprio in virtù delle sue potenzialità magiche) che si occupava altresì di culti privati e di pratiche magico-religiose.
Il primo a combinare i termini
goetéia e
maghéia è Gorgia, nell'
Elogio di Elena:
«
Di fascinazione e magia si sono create due arti, consistenti in errori dell'animo e in inganni della mente».
In generale possiamo dire che la magia inizia a configurarsi come un ambito d'azione ben preciso, distinto dalla religione (sebbene non a esso opposto, come si vedrà più avanti) nel momento in cui viene a formarsi una teologia precisa e si attestano le scienze naturali: in questa prospettiva, filosofi e scienziati diverranno - almeno apparentemente - nemici agguerriti dei maghi, considerati ciarlatani e impostori. In realtà, come si avrà modo di apprendere, magia e religione (soprattutto magia e religioni misteriche) si confonderanno spesso e volentieri, creando un affresco dai contorni e dalle tinte a prima vista confusi.
La terminologia romanaA Roma, i termini
magus e
magia vengono mutuati ovviamente dal greco; ma ciò avviene solo molto tardi, intorno al I secolo a.C. (cfr. Catullo e Cicerone,
De divinatione e
De legibus).
Se vogliamo rintracciare le parole esatte utilizzate per indicare l'attività di incanto e fascinazione (più o meno nociva), dobbiamo risalire alle Dodici Tavole, la cui terminologia si tramandò senza dubbio alcuno anche in età repubblicana. Infatti, se
magus e
magia divennero celebri nella prosa di Cicerone e nella poesia di Virgilio, in età augustea (riprendendo in questo senso il gusto poetico alessandrino), nel
corpus legislativo delle Dodici Tavole si legge:
«
Ne quis alienos fructus excantassit» ("Affinché nessuno faccia scomparire con incantesimi il raccolto di un altro", tramandatoci da Seneca).
Cita altresì Plinio il Vecchio:
«
Qui fruges excantassit et alibi qui malum carmen incantassit».
Da notare che si tratta in entrambi i casi di magie relative alla sottrazione dei frutti del lavoro agricolo altrui: di un vicino, di un conoscente... La legge non punisce la magia, ma il furto attuato per suo tramite. Lo stesso accadeva ad Atene, dove non esistevano leggi specifiche contro le maledizioni magiche: per questo ce ne sono pervenute in gran numero proprio dall'Attica.
Particolare importanza aveva inoltre a Roma il
veneficium, unica spiegazione plausibile nei casi di
mors improvisa, per utilizzare la definizione di Ariès. Ce ne parla Tito Livio (VIII, 18), raccontando della morte misteriosa e repentina di alcuni
primores civitatis (uomini pubblici di spicco), avvenuta nel 331 a.C., della quale furono accusate alcune nobili matrone: costrette a bere in tribunale i veleni che presumibilmente avevano preparato e somministrato agli uomini, morirono tutte all'istante.
Al di là della terminologia usata (
carmen,
mala carmina,
magia...), va rilevato che la magia, nella Roma antica, passò attraverso due fasi distinte:
1) in età repubblicana si distingueva fra pratiche che nuocevano alla proprietà privata o alla salute delle persone (
veneficium) e l'insieme di tutti gli altri rituali magici, privi di intenzioni malefiche: fra magia negativa e magia innocua, dunque;
2) in età giulio-claudia, il delitto di
veneficium (avvelenamento) viene distinto dalla magia vera e propria e condannato come crimine puro e semplice.
[Continua.]
,+Greek..jpg)